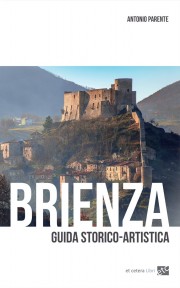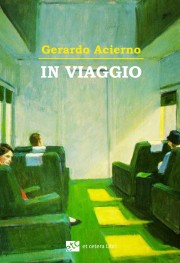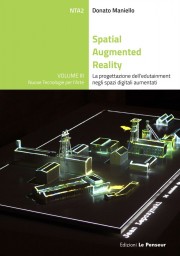L’“ottocento” attraversato dalle tante storie, almeno cinque quante le parti del libro, raccontate da Dino Collazzo si riferisce all’“altra Europa” di Galasso, qui rappresentata da un “pezzo d’Africa europeo”, da una Brienza che assurge a caso emblematico dei periferici centri abitati del Mezzogiorno appenninico. Si tratta, pertanto, di un Ottocento meridionale che, come nell’intero Occidente, è avvio di trasformazioni profonde e processi contemporanei, ma che, a differenza delle aree più avanzate dell’Occidente, è anche resistenza al mutamento, ricezione della modernizzazione a livello formale ed esteriore, sopravvivenza di modelli arcaici o, al più, feudali. Un Ottocento che qui è più lungo che altrove, per alcuni aspetti addirittura non ancora concluso. Il dolce desiderio di cercare i volti delle persone che hanno abitato i luoghi che oggi sono i nostri, di ricostruire i rapporti che le legavano ed i progetti che le spingevano ad agire, qui conduce all’amara storia di una comunità divisa dalle continue dispute animate dai ceti dirigenti, da gruppi familiari condannati dalla circostanza di vivere in prossimità, ma incapaci di valorizzare il senso dello stare insieme ed individuare obiettivi comuni da perseguire attraverso la collaborazione. Riemergono, contro le attese di trovare conforto almeno nelle memorie del passato, liti e contese trascinate per anni, miopi tentativi di avvantaggiarsi combattendo coloro che sono percepiti solo come avversari, dinamiche riferibili più alla dimensione clanica o tribale che ad una moderna organizzazione sociale. Sicché si giunge a pensare che non ci sia più niente da capire, da fare, finanche a sperare che, “litigiosi, inaffidabili, infidi, falsi e spergiuri” così come sono ritratti da memorie familiari ed atti giudiziari, infine “questi miserabili individui si scannino l’un l’altro, fino a estinguersi”. Sarebbe un errore attribuire la propensione ad animare faide paesane, l’evidente deficit di coesione sociale alla sola realtà brienzana, giacché viceversa essa ben rappresenta la maggioranza dei paesi e delle città del Sud d’Italia. Così come sarebbe sbagliato attribuire tali caratteri ad una dimensione antropologica dei meridionali, quasi ad un elemento naturale ineluttabile ed irredimibile. Piuttosto è l’analisi dei processi storici ad evidenziare come le principali trasformazioni avvenute durante il lungo Ottocento meridionale non siano state quasi mai il frutto di un progresso culturale endogeno, sospinto dalle élite e diffuso nel resto del popolo, bensì il risultato di importazioni, di trapianti affrettati di sistemi legislativi ed istituzionali altrove nati ed evoluti. L’abolizione della feudalità e la nascita dello Stato moderno con l’innovativa organizzazione dei poteri pubblici costituirono il grazioso dono delle armate napoleoniche e di governanti francesi, così come l’introduzione della democrazia liberale, delle garanzie costituzionali e della rappresentanza parlamentare furono consentite dai volontari garibaldini prima e dalla monarchia sabauda poi. E probabilmente risulta fuorviante la tendenza ad enfatizzare ed esaltare, nella maggior parte dei casi per l’esigenza di celebrare valori civili e piccole patrie, il ruolo delle élite meridionali all’interno di tali processi di modernizzazione. Più utile, viceversa, rimane la lezione di Vincenzo Cuoco, relativa alla drammatica frattura tra intellettuali e ceti popolari nella rivoluzione del 1799, che resta preziosa chiave di lettura anche per interpretare i successivi fallimenti. Filosofi, giuristi, economisti, i quali parteciparono attivamente alla stagione dell’illuminismo europeo, furono in molti casi originari di piccoli centri di provincia, ma si formarono ed assunsero elevata statura solo grazie al trasferimento a Napoli ed all’opportunità di prendere parte al ristretto circolo di intellettuali che gravitava intorno all’ateneo partenopeo. L’Ottocento di Brienza narrato da Dino Collazzo attraverso la documentazione archivistica non presenta tracce né di Mario Pagano, né degli altri intellettuali nati e legati al centro lucano, ben evidenziando la loro estraneità rispetto ad un corpo sociale di cui a torto spesso sono ritenuti espressione. Allo stesso modo, il loro magistero rimase oscuro ed incompreso alla gran parte della popolazione, parimenti a quella residente nei loro luoghi di origine. E non tanto per la distanza fisica o per le difficoltà di comunicazione, quanto per l’assoluta discordanza dei valori etici di riferimento, essendo quelli della piccola e media borghesia locale dominati pressoché esclusivamente dal particolarismo e dall’opportunismo. Le scarse opportunità di sviluppo economico, gli ostacoli frapposti dal difficile contesto geografico alla circolazione di merci ed idee, la tradizionale debolezza del ceto medio contribuirono inoltre a non cogliere il senso profondo delle trasformazioni collegate alla generale modernizzazione. Cosicché le forme di organizzazione della vita pubblica, che in altri territori avevano accompagnato ed assecondato progresso civile e benessere materiale, nel Mezzogiorno furono ridotte a strumenti per continuare ad affermare i tradizionali privilegi e conservare inalterate le distanze tra ceti sociali. I casi di mala giustizia a Brienza narrati dall’Autore esemplificano efficacemente le difficoltà nel rinnovare l’organizzazione giudiziaria secondo i provvedimenti adottati durante il Decennio francese, evidenziando come l’impreparazione dei magistrati, l’indolenza causata dall’operare in sedi considerate secondarie e la soggezione ai ceti più elevati vanificassero il tentativo di tradurre nella realtà gli alti ideali affermati dai philosophes. Certo, in molti casi le riforme consentirono l’emergere di uomini nuovi; cogliendo le opportunità offerte durante le concitate fasi di cambiamento alcune famiglie di più modesta condizione riuscirono ad ascendere a livelli più alti, ma quasi sempre anche i nuovi proprietari si adattarono ai tradizionali canoni comportamentali, riferibili al radicato modello feudale, alla rendita parassitaria ed allo sfruttamento dei contadini senza terra. In tale contesto, evidentemente, anche gli schieramenti politici, ed in particolare la distinzione all’interno di ogni centro abitato meridionale dal 1799 in poi tra sostenitori delle idee della rivoluzione e difensori dell’ancien régime, quasi sempre non sono strumento di dialettica democratica e confronto di idee, ma motivo di scontri infiniti tra fazioni contrapposte. Nell’ultima parte di questo libro, quella che è quasi un romanzo o il testo di un dramma teatrale, Dino Collazzo attinge agli atti processuali dell’epoca per portare alla ribalta i brienzani della prima metà dell’Ottocento, con i loro nomi, gradi di parentela ed attività lavorative. Dall’icastica scena emerge l’immagine di una borghesia spaccata in due partiti, i quali, “volubili secondo le diverse circostanze”, sono impegnati “in un gioco di convenienze e riposizionamenti dettato solo dal particulare”. In mezzo, “fra due fuochi”, il resto dei brienzani, che “non sapeva più a chi dar retta”: contadini, proprietari di poco o niente, comparse, attori muti di una trama, di una storia che non era la loro.